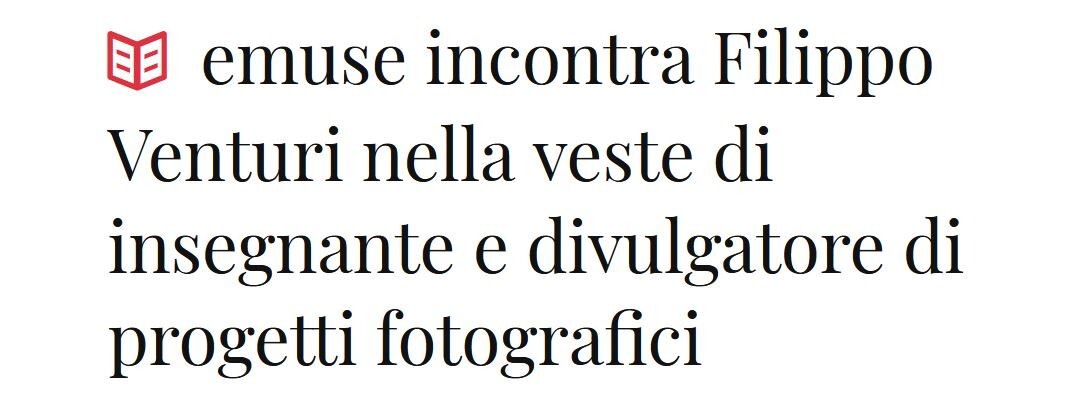E’ uscito sul sito della Casa Editrice emuse, una intervista nella quale parlo dell’ultimo libro fatto insieme, “My Dear”, che contiene il risultato del Laboratorio fotografico omonimo che ho condotto, in collaborazione con l’associazione Between, nell’ambito del progetto europeo Shaping Fair Cities. Questo laboratorio ha visto protagoniste 20 donne di 9 nazionalità diverse!
L’articolo originale è disponibile qui: emuse incontra Filippo Venturi nella veste di insegnante e divulgatore di progetti fotografici
IL LIBRO
Fotografie di: Barbara Kulik, Graziella Paganelli, Ilaria Liu, Ilaria Zozzi, Khadija M'Goun, Kinga Paprota, Livia Cartas, Lorenza Fabbio, Mariama Dieng, Marina Bellavista, Nadiia Kovalchuk, Salomè Emperatriz San Martin, Svetlana Mocanu, Yujuan Chen.
Testi di: Luciana Garbuglia (presidente dell’Unione Rubicone e Mare), Valeria Gentili (presidente dell’Associazione di promozione sociale Between), Elena Dolcini (Curatrice e Critica d’arte), Filippo Venturi (Fotografo e Docente del laboratorio)
Casa editrice Emuse, ISBN: 978-88-32007-42-8
Direttore editoriale: Grazia Dell’Oro
Coordinamento editoriale: Filippo Venturi
Progetto grafico: Denis Pitter
Il laboratorio “My Dear”, inserito all’interno del Progetto europeo Shaping Fair Cities, è stato rivolto a venti donne che vivono in Romagna (a Savignano sul Rubicone, Cesenatico, Sant'Angelo di Gatteo, San Mauro Pascoli e Gatteo) e coinvolte dall’Associazione Between. Le protagoniste sono di nove nazionalità diverse (italiana, rumena, polacca, bulgara, ucraina, cinese, peruviana, senegalese e marocchina), hanno un range di età che va da 22 a 65 anni e lavorano in diversi ambiti: assistenti familiari, impiegate, operaie, mediatrici culturali, bariste, ecc.
La finalità del laboratorio era il perseguimento dell’Obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030: “raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”.
Alle donne coinvolte nella realizzazione di un proprio progetto fotografico, sono state assegnate delle macchine fotografiche usa e getta con rullini da 27 scatti (con alcune eccezioni dettate da scelte tematiche o visive che hanno richiesto l'uso di altri mezzi). Questa scelta è stata dettata dal desiderio di fornire uno strumento di lavoro dedicato, che non fosse fonte di distrazione (come può essere uno smartphone) e col quale fosse necessario fermarsi a riflettere prima di fotografare, avendo un numero predefinito di tentativi. Avere delle limitazioni (di spostamento a causa della pandemia, di numero di scatti realizzabili, ecc.) spinge le persone a prendere coscienza della situazione e a ingegnarsi per trovare una via per esprimersi.
Il laboratorio è stato avviato nell’autunno 2020 ed è durato circa sei mesi. L’ideazione e la progettazione risalivano a dodici mesi prima, quando ancora le nostre vite non erano state stravolte dal Covid-19. La pandemia ha trasformato questo percorso rendendolo tortuoso e mettendone a rischio il raggiungimento del traguardo ma, presto, ha reso più coeso il gruppo, consentendogli di attraversare la tempesta e uscirne rafforzato.
La condivisione delle difficoltà nel periodo di emergenza sanitaria, gli stratagemmi digitali per mantenere il contatto anche quando il lockdown impediva di incontrarsi, il desiderio di raccontare con la fotografia le proprie vite, ha portato a un risultato profondo e interessante. Come spesso accade, le esperienze più segnanti sono quelle che si portano a termine fra imprevisti e difficoltà.
I progetti realizzati si sono focalizzati su storie personali, confidenze, ma anche sui rapporti sociali che abbiamo dovuto rivedere a causa del distanziamento sociale e dei dispositivi per prevenire il contagio. Da questo percorso è scaturito un universo di testimonianze costellato da sensibilità distinte, provenienze diverse, approcci disparati, ma tutte convergenti nel bisogno di ricevere e offrire, oggi più che mai, ascolto, comprensione e vicinanza.
Lo strumento fotografico per un lungo periodo è stato riservato a pochi professionisti. Da diverso tempo però si è assistito a un rapido processo di “democratizzazione” della fotografia. Chiunque può scattare una fotografia, anche senza strumentazione specifica, e può avere un ruolo da protagonista nel flusso comunicativo. Non solo, con le fotografie si può contribuire ad attivare processi sociali e influenzare la percezione pubblica.
L’INTERVISTA
Filippo Venturi ha recentemente organizzato un laboratorio fotografico in collaborazione con l’associazione Between nell’ambito del progetto europeo Shaping Fair Cities. Il laboratorio ha coinvolto venti donne di diverse nazionalità residenti in Romagna e dai loro lavori è nato un libro edito da emuse: My Dear.
Grazia Dell’Oro l’ha intervistato.
Filippo, durante questo ultimo anno, nonostante la situazione pandemica, sei stato molto attivo. Hai prodotto lavori che sono stati pubblicati su importanti riviste. In che modo questa nuova situazione che stiamo vivendo ti ha stimolato?
Inizialmente la pandemia ha rappresentato un blocco: oltre a dover rinunciare ad un grosso progetto in Cina, molti eventi che avrei dovuto documentare solo saltati. Per fortuna, pochi giorni dopo l’inizio del primo lockdown in Italia, qualcosa è scattato dentro di me e ho iniziato a documentare la pandemia sotto tutti i punti di vista che ritenevo interessanti. Solitamente non lavoro sulla stretta attualità, ma in questo caso mi sono trovato proprio al centro dell’attualità (l’Italia è stato il primo paese occidentale a subire i primi gravi effetti del Covid-19). Il primissimo lavoro che ho svolto è stato ritrarre e intervistare 40 rider sul cancello di casa mia; un’idea semplice ma efficace per adattarmi ai limiti imposti dal lockdown e che ha colpito molto i photoeditor di The Guardian che gli hanno dato ampio spazio. Poi, spinto dai primi buoni risultati, ho continuato la mia documentazione anche all’esterno, nel mio quartiere, in ospedale, nelle case dei malati, nel settore teatrale, ecc. e sono arrivate pubblicazioni su The Washington Post, Marie Claire, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, ecc. È stata una esperienza molto formativa e positiva. Sono soddisfatto della reazione che ho avuto: tentare di rimanere lucido e attivo. Penso che ciò mi abbia permesso anche di non subire troppo gli effetti psicologici negativi di questo evento epocale.
My Dear è stato pensato come laboratorio di fotografia partecipativa. Come è nato e quale è stato l’intento del lavoro che hai condotto con le donne che hanno aderito?
Da alcuni anni mi è capitato di essere coinvolto, da parte di alcune Associazioni con cui avevo già collaborato, in alcuni progetti finanziati dall’Unione Europea o da altri Enti statali. È un settore che, se sfruttato a dovere (non a caso ci sono professionisti che si specializzano nel cercare questi bandi e nel preparare i progetti), consente di accedere a risorse importanti per sviluppare percorsi molto utili a livello sociale e anche artistico. Il laboratorio My Dear nasce all’interno del Progetto europeo Shaping Fair Cities ed ha come finalità perseguire l’obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030, cioè “raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”.
Credo che si possa dire che gli esiti del laboratorio sono stati superiori alle aspettative, per qualità e coerenza dei lavori fotografici. Quando ti sei reso conto che, in qualche modo, l’idea aveva attecchito?
In una prima fase mi ha colpito notevolmente la partecipazione delle venti donne che si sono interessate al laboratorio. Con la pandemia che colpiva ripetutamente il paese e rendeva impossibile condurre una vita sociale normale, mi ero rassegnato a veder ridursi il numero delle partecipanti, invece c’è stato uno spirito di adattamento notevole: se non potevamo incontrarci di persona, organizzavamo delle webcall, se non tutte riuscivano ad essere presenti, organizzavamo delle sessioni dedicate in qualunque giorno della settimana e orario. Se nemmeno quello era possibile, usavamo Whatsapp per comunicare, vedere il materiale prodotto e confrontarci. A livello umano è stata una esperienza incredibile e questo desiderio comune di portare a termine il percorso iniziato insieme avrebbe rappresentato già un grande traguardo. Poi, vedendo il frutto dei loro progetti, pur non essendo fotografe esperte, mi rendo conto che il risultato è andato oltre ogni aspettativa!
Come intendi sviluppare le esperienze che stai raccogliendo come insegnante o animatore di gruppi che hanno come obiettivo l’indagine sul tema dell’identità attraverso il mezzo fotografico?
Fino a qualche anno fa non mi vedevo a tenere corsi di fotografia (ero molto concentrato su di me e i miei progetti) eppure, assecondando alcune richieste, ho scoperto che mi piace insegnare. Lo stesso è accaduto con questi laboratori dove, oltre all’insegnamento, c’è una fase importante di incontro e conoscenza con i partecipanti e sviluppo di progetti individuali che però siano legati da un filo conduttore. Ho ricevuto diverse proposte per continuare a lavorare anche in questo settore e un paio di progetti saranno avviati questa estate e nel prossimo autunno. Anche questi li sento ormai come “miei progetti”, semplicemente sono svolti come se io e i partecipanti fossimo una sorta di collettivo.
Filippo, ci siamo conosciuti in occasione dei tuoi lavori Made in Korea & Korean Dream, un ambizioso progetto che intendeva mettere in relazione e a confronto le due Coree, gli esiti differenti di una storia tanto comune quanto, da un certo momento in poi, divergente. Come senti quei due lavori a qualche anno di distanza?
Sono lavori che stanno invecchiando bene. Le tematiche su cui ho focalizzato i due capitoli del progetto, uno sulla Corea del Sud e l’altro su quella del Nord, sono ancora molto attuali e i lavori, pur a distanza di diversi anni, stanno attirando ancora attenzioni, riconoscimenti e proposte espositive (alcune sono in sospeso, in attesa di capire come svolgerle compatibilmente con l’emergenza sanitaria). Sicuramente rappresentano un passaggio importante nel mio percorso di fotografo documentarista e anche come autore. A proposito, nel corso dell’ultimo anno mi sono annotato diversi temi e fenomeni, sempre riguardanti la penisola coreana, che vorrei approfondire e non escludo di tornarci nel prossimo futuro!
Filippo Venturi è nato a Cesena nel 1980. Fotografo documentarista. Realizza progetti su storie e problematiche riguardanti l’identità e la condizione umana. I suoi lavori sono stati pubblicati su giornali come The Washington Post, The Guardian, Financial Times, Newsweek, Geo, Vanity Fair e Internazionale. Negli ultimi anni si è dedicato a un progetto sulla penisola coreana. Insegna fotografia e conduce workshop fotografici nell’ambito di diversi progetti europei.
Con emuse ha pubblicato Made in Korea & Korean Dream.